Novembre 2019 – CII e CISI – Come promesso pubblichiamo sul Sito, la riflessione proposta per il mese di novembre per l’animazione comunitaria, tratta dal testo PUOI ESSERE SANTO #lìdovesei – BEATI I POVERI: ossia della sapienza evangelica – Costituzioni SDB art. 33 e Costituzioni FMA art. 11 – L’icona evangelica più sconcertante e vera della povertà è quella che ci presenta Paolo nelle forti e incisive parole nella Lettera ai Filippesi al capitolo due: “spogliò se stesso, assumendo la condizione di servo…”. Spogliò se stesso. È la povertà dell’essere.
Il consiglio evangelico della povertà coinvolge la totalità della persona e dell’essere. Investe non soltanto il possesso delle cose, ma ogni altra realtà che dia una qualche sicurezza: le cose, gli altri e lo stesso Dio. Roger Schutz, monaco di Taizè, in Dinamica del provvisorio a pag. 48-49 scrive: «Non bastano i segni esterni della povertà; essi non impediscono di conservare in sé un’ambizione umana, un bisogno di potenza, un desiderio di dominare il prossimo, appena mascherati dalle apparenze. Per poter vivere la povertà nell’ottica evangelica è necessario verificare il proprio atteggiamento nei confronti della vita, che può essere sentita o come dono o come cosa propria. Ciò richiede un processo di maturazione della persona verso un’identità fondata sull’essenzialità e sull’interiorità». E Carlo M. Martini commenta: Povertà e identità dei consacrati sono dunque fondamentalmente collegate. Questo però esige un cammino di maturazione che ci conduca alla consapevolezza che il consiglio evangelico della povertà, pienamente vissuto, libera dal pericolo di essere invischiati nella seducente ricchezza del possedere, del sapere e del potere, libera dalla schiavitù dei nostri bisogni e desideri, dall’ansietà connessa con l’acquisto dei beni materiali e dalla tirannia del consumismo. La povertà è uno stile di vita, lo stile delle persone abitate dal Signore, innamorate di Dio, lo stile delle persone mistiche. La povertà diventa il volto più vero della sapienza evangelica che non è la sapienza dell’avere, del potere, dell’autorealizzazione, dell’autosufficienza e del fare… La povertà chiede un attitudine interiore di passività, cioè il lasciarsi fare, il riconoscere il nostro vuoto, le nostre inconsistenze, la nostra radicale impotenza.
I volti interiori della povertà sono la carità, l’umiltà, la gratuità. La povertà ha una radice: l’amore. Amare è darsi, perdersi, consegnarsi. L’amore è il dolce pedagogo che ci conduce lentamente ma inesorabilmente alla povertà. Genera un meraviglioso frutto: la libertà. “Nulla mi turba, tu solo mi basti! L’umiltà è l’espropriazione dell’io, proprio quello che chiede l’essere povero. Non a caso ci sono esegeti che oggi traducono l’espressione semitica «poveri in spirito» con «umili di cuore». L’uomo umile, non è più un concorrente di Dio, non è più un oppressore dei fratelli, un avido di contare, un narcisista, un ambizioso: è un beato. È una creatura pacificata dall’abbandono nel Signore. La sua umiltà non si ferma a livello dello stato d’animo, dei sentimenti e delle intenzioni del discepolo del Signore, ma scava la sua esistenza rendendola essenziale, lo coinvolge in esperienze di croce e spesso assapora l’amaro delle sconfitte. È un’umiltà concreta ma felice! Conosciamo più facilmente una umiltà rassegnata, accolta con disagio interiore o sentimenti di inquietudine. E’ a volte persino una umiltà che possiamo definire “eroica”. Ma meno frequentemente viviamo una umiltà felice. Chi è contento di non valere niente, di non sentirsi stimato? Chi è contento di avere l’ultimo posto? Ma è proprio questa la beatitudine della povertà. Non contare! L’umiltà di cuore è una scelta di vita, dove il «non contare», «l’ultimo posto», lo «spogliamento» come dice l’apostolo Paolo parlando di Gesù (cf Fil 2,7 8), devono diventare cose vissute. E questo perché il Signore cresca in noi, perché lui solo sia glorioso. Anche quando la gloria è un possesso. Il povero di Dio non cerca la sua gloria. La gratuità è donare perdendo: ogni diritto, ogni attesa, esigenza e soddisfazione…
Dal disagio della “mancanza” alla gioia della “beatitudine”. La povertà come “mancanza” in se stessa non è un bene: ha una connotazione chiaramente negativa, perché la mancanza di qualcosa genera disagio, sofferenza, bisogno, ansietà. Il problema però non si situa a questo livello. Sotto il profilo psicologico, anche la mancanza e il disagio conseguente possono assumere un significato positivo di crescita. Infatti, ogni frustrazione derivante dalla mancata soddisfazione di un bisogno attiva a livello motivazionale spinte interiori di ricerca e di azione, di risalita, che non sono affatto negative. Pensare alla povertà significa anzitutto porsi in atteggiamento di contemplazione di Cristo crocifisso, prendere coscienza di chi siamo, della dignità dell’uomo secondo il piano di Dio. È pienezza di donazione accolta, condivisa, partecipata, accresciuta, incrementata. È invito a lasciarsi colmare dalla ricchezza di Dio perché ci trasformi in pane di vita che nutre i fratelli. Siamo anche noi la vedova di Zarepta: “Per la vita del Signore tuo Dio, non ho nulla di cotto, ma solo un pugno di farina nella giara e un po’ di olio nell’orcio; ora raccolgo due pezzi di legna, dopo andrò a cuocerla per me e per mio figlio; la mangeremo e poi moriremo”. 1Re17,12. Essere povero, nel senso evangelico, significa accogliere il disegno del Padre in Gesù Cristo e coltivare intelligenza, cuore, opere, sogni, fantasie e progetti per far sì che il piano del Padre si realizzi in noi e attraverso di noi per il bene di tutti. Scrive al riguardo il Guillet: «Gesù non si appartiene e uno dei segni di questa rinuncia è il suo modo di vivere nel tempo. Una delle forme di ricchezza è avere del tempo davanti a sé, poter disporre a piaci-mento dei momenti che vengono, usarli a modo proprio. Ora Gesù vede la propria esistenza asservita e spogliata di se stessa. Non un istante che gli appartenga e di cui egli disponga a piacimento, il suo tempo non gli appartiene, ma è tutto consacrato al Padre e alla sua opera. Il suo tempo non è suo, ma di tutti quelli che hanno bisogno di lui. Egli lo riceve dal Padre non come un tesoro di cui disporre a piacimento, ma come un deposito di cui rendere conto».
La povertà stile di presenza personale e comunitaria. Essa si esprimerà in atteggiamenti che portano ad assecondare la costruzione della comunità secondo il suo sogno: essere una cosa sola. Essere povero per una comunità cristiana e religiosa significa non porre resistenze allo Spirito, assecondare la consapevolezza di essere amati da Dio, essere chiamati ad aiutarci reciprocamente, a sprigionare la capacità di condurre avanti iniziative che inducono a diventare soggetto con tutti e verso tutti. L’uomo è povero dell’uomo! Non possiede l’altro perché egli è di Dio e di se stesso. Povero è l’uomo dai desideri umani. Non è povero chi è privo di desideri, ma l’uomo che coltiva desideri degni dell’uomo, di una creatura che in Gesù Cristo è innestata nel disegno del Padre. La povertà equilibra la tensione verso le persone e verso le cose, modera la brama di possedere e la tendenza ad emarginare. Il povero essenzializza il possesso degli oggetti e alimenta l’aspirazione alla fraternità e alla convivenza, frena la sete di potere e accresce le iniziative di promozione. Vivere la povertà accresce in noi la capacità di nutrire verso l’altro sentimenti di attesa, di riconoscimento e di rispetto. Nessuno, per qualsiasi motivo, dovrebbe pretendere di dominare l’altro, e lo si domina anche quando lo si emargina, ci si disinteressa di lui, lo si tratta come cosa, non si coltiva la capacità di operare perché la sua situazione diventi umana. L’ascesi della povertà deve mirare a liberare la capacità di un amore fattivo, non a parole. “Non amiamo a parole… ma con i fatti e nella verità” 1Gv 3,8. Il povero soffre se l’altro non si realizza. Spesso con il pretesto di aiutare gli altri a trovare la via, diventiamo dispotici, possessivi, li coartiamo, non li sosteniamo nel loro cammino di liberazione. Il povero dona gli uomini a se stessi, fa spazio in sé alla libertà degli altri anche quando non sono capaci di amare. Quanto è facile per noi religiosi lasciarci illudere dal fatto di essere economicamente poveri, ma poi diventiamo profondamente possessivi! Presumiamo di dominare, controllare pensieri, affetti e comportamenti. Ma poi diventiamo incapaci di accettare che siano messi in discussione i nostri piani e ci nascondiamo dietro proclamate e non vere condizioni di povertà!
La povertà è apertura al futuro, superamento della paura del non-ancora. Il povero non è idolatra. L’idolatra vuole conoscere, disporre, controllare tutto, si pensa misura del bene e del male degli altri e della loro vita. È incapace di far credito all’invisibile. Il povero rispetta e adora il mistero. Per approfondire il senso della povertà si possono considerare due aspetti: la povertà delle persone come dramma di solitudine e come rapporti non rispondenti alle nostre esigenze. Nella nostra vita, abbiamo istintivamente bisogno di supporti umani, di qualcuno che ci gratifichi. In qualunque situazione ci possiamo trovare, abbiamo l’ansia del parere degli altri, il desiderio che qualcuno ci dia ragione; bramiamo che il fratello ci tenda una mano, ascoltandoci nel nostro sfogo. La solitudine spesso ci fa paura. Ma, quando cerchiamo in modo eccessivo l’appoggio psicologico o affettivo degli altri, rifuggendo la solitudine, non siamo poveri. La povertà di persone è amore alla solitudine, non come fuga, ma come serena relazione con gli altri, senza esigere il loro appoggio.
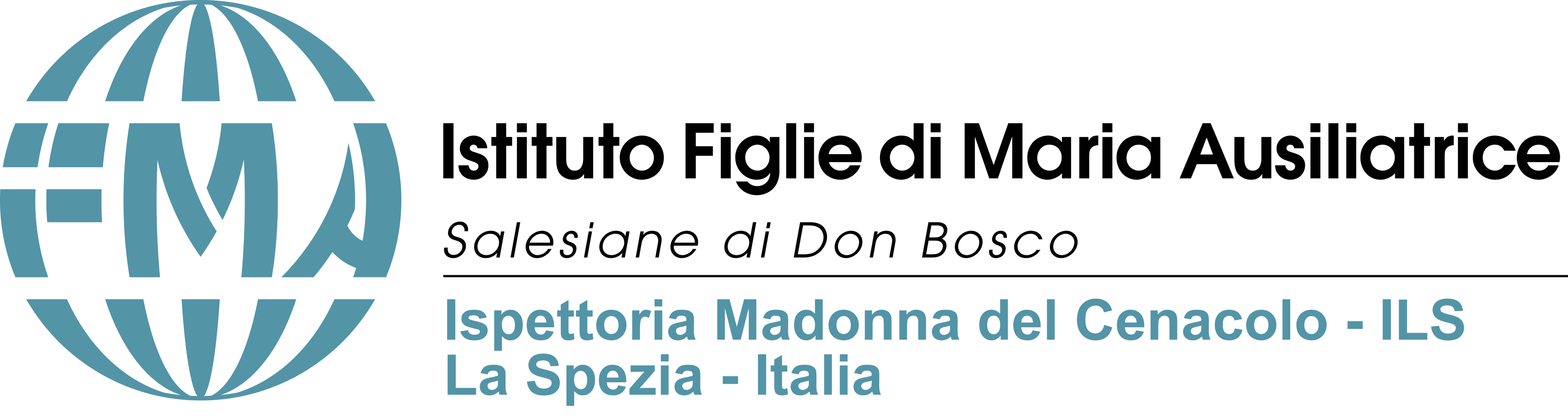
Lascia un commento